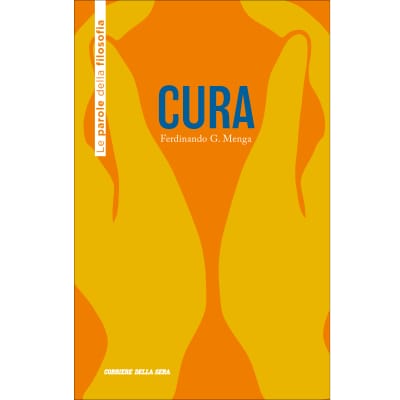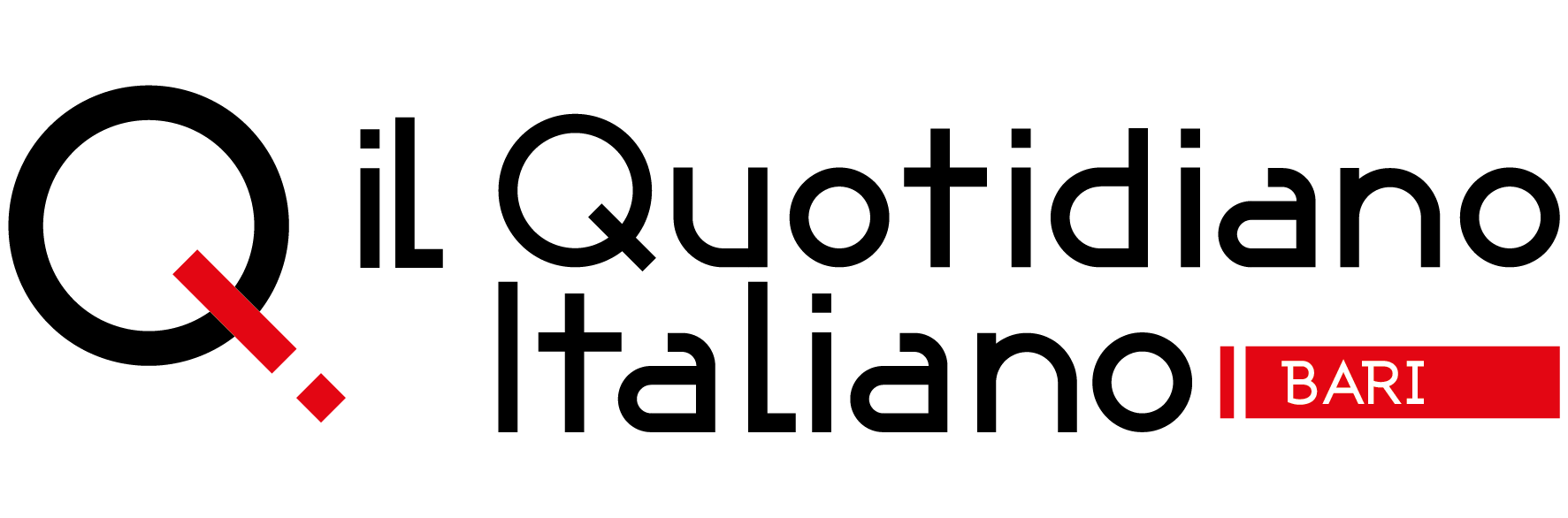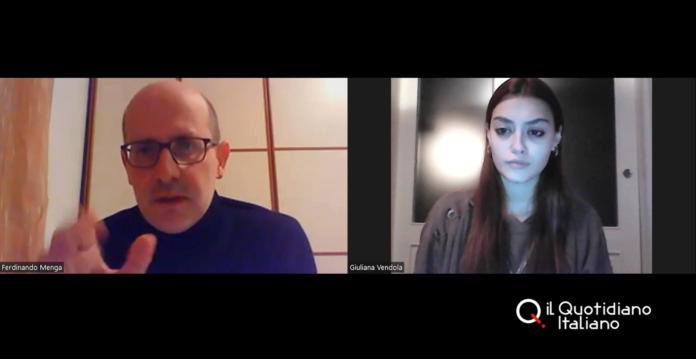
“Mi fa male il mondo, mi fa male, e non riesco a trovar le parole per chiarire a me stesso e anche al mondo cos’è che fa male“, cantava l’immenso Giorgio Gaber nel 1995. Quei discorsi sofferti e non detti di cui parlava il lungimirante Signor G., concetti pensati, ma all’epoca nascosti sotto il tappeto, perché non si era raggiunta la consapevolezza dei danni inferti dal progresso al pianeta e ai suoi abitanti, sono oggi, a distanza di trent’anni svelati e sviscerati dal professor Ferdinando Menga nel libro “Cura”, il 13esimo volume della collana “Le parole della filosofia” in edicola da domani, 10 febbraio, con il Corriere della Sera. L’autore di nascita pugliese, docente di Filosofia del Diritto all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Adjunct Research Fellow presso l’Università di Tübingen, nonché co-direttore delle riviste “Etica & Politica” ed “Endoxa/Prospettive sul presente”, non è solo un accademico, ma tra i più lucidi osservatori del cambiamento etico e politico compiuto dalle generazioni nel corso dei tempi.
Professore nel suo ultimo libro racconta di come la pandemia da Covid-19 ci abbia ricordato di essere vulnerabili, svelando una crisi di portata globale della cura. Che significa?
La cura risulta essere un aspetto costitutivo delle nostre esistenze. Ciascuno di noi è diventato ciò che è attraverso una cura che ha iniziato a sortire i suoi effetti fin dalla tenera età. Tuttavia, se da una parte la cura ha questa natura capillarizzata che domina l’esistenza, quasi sorprendentemente la nostra cultura e tradizione l’hanno sempre relegata in uno scantinato, in una dimensione di importanza secondaria, laddove invece i grandi temi della politica sono quelli che dominano lo spazio pubblico. Bisogna domandarsi come mai questa discrasia, questa opposizione fra una importanza così evidente della cura e una dimensione di attenzione marginale agli elementi della cura. Tutto ciò è perché questo tipo di marginalizzazione e, direi, opacizzazione della cura, è sempre stata funzionale a un modo di far funzionare la nostra cultura, ma anche la nostra economia. Si tratta di uno stile di vita improntato non a soggetti vulnerabili e interdipendenti, bensì a soggetti capaci di offrire prestazione, di produrre ed essere funzionali alle leggi di mercato e all’economia capitalistica. Questa relegazione della cura fa il palio con una relegazione della vulnerabilità che un sistema fondato sulla produzione e sul consumo non può accettare. Tanto più si relega ai margini un aspetto fondamentale dell’esistenza, quanto più accade che traumaticamente da sotto la cenere questo aspetto ritorna in momenti fondamentali di crisi e uno di questi è stato proprio la pandemia. Ormai tutti sappiamo che la pandemia è stata provocata dal fare usurpatorio e predatorio dell’essere umano sul pianeta, e dunque in qualche modo la vulnerabilità che abbiamo subìto in questo periodo ci ha mostrato che avremmo dovuto occuparci dell’aspetto della cura. La pandemia è stata un evento traumatico che ci ha dato l’occasione di ritornare a quelli che sono gli elementi fondamentali della nostra esistenza. Nel nostro essere tutti vulnerabili abbiamo scoperto che il nostro esistere è tenuto in piedi dalla capacità di accogliere la nostra vulnerabilità e dunque di prestare continuamente una cura adeguata, affinché noi possiamo vivere e convivere in equilibrio con il pianeta.
Lei parla in questo volume di quanto siamo concentrati sull’hic et nunc che ci fa perdere di vista il futuro. Temi che ha trattato anche nelle sue celebri opere “L’emergenza del futuro” ed “Etica intergenerazionale”. In questo mondo post-Covid19 è cambiato il modo di intendere il presente?
C’è stata una fase in cui il Covid ha dato l’opportunità di accorgerci nel vissuto profondo di questa vulnerabilità, non abbiamo potuto evitarla. Abbiamo avuto la possibilità di sospendere le nostre vite e cercare di capire che il pianeta e tutti noi avevamo bisogno di una cura che guardasse al futuro con uno stile diverso, come un altrimenti rispetto allo status quo. E qui in qualche modo una forma di critica del presente poteva nascere e tant’è vero che i lemmi con cui si parlava davano uno slancio verso il futuro come posta in gioco dell’oggi. Però, è come se, e qui non posso fare altro che essere pessimista, si sia tornati a recuperare quelle piccole certezze e quello status quo che nasconde squilibri e dissimmetrie fortissime nei confronti dei vulnerabili di oggi, ma anche dei vulnerabili di domani. Perché vi è una continua caccia predatoria e usurpatoria di un accaparrarsi sempre più energia soltanto per crescere, senza interrogarsi su ciò che questa caccia espansionista provocherà, che i futuri si troveranno come dice Bernard Stiegler “condannati come umanità di serie B ad accontentarsi dei nostri pochi e avvelenati resti”. Dunque essere fissati sul presente, senza vedere il futuro come posta in gioco della nostra responsabilità, è un’azione politica carica di conseguenze miopi e ingiuste. Parlo di una sperequazione tra contemporanei, ma anche un’iniquità tra i forti di oggi e gli inermi di domani, sia umani che animali. Questi ultimi addirittura sono riemersi durante la pandemia, si sono riappropriati dei luoghi in cui li avevamo relegati e questo ci ha detto che il pianeta è un luogo di coabitazione tra umani e non umani.
I millennials stanno dimostrando di avere a cuore l’ambiente e la sopravvivenza del pianeta, sembra siano più responsabili di genitori e classe politica. Come mai?
Qui mi riferisco di nuovo a Stiegler che ha parlato di “una perversione pedagogica“. L’esasperazione neoliberista della nostra economia che si concentra su una visione dell’umano come homo economicus che deve soltanto produrre, depredare, consumare e accrescere, è concentrata sul fatto che questo processo continui indisturbato. Ma questo processo può continuare solo se c’è un’opzione etica-temporale precisa: dobbiamo fregarcene del futuro. Perché se il futuro diventa un problema etico, un problema di responsabilità, allora questo sistema dell’illusione di crescita continua non può funzionare, in quanto le risorse sono limitate. Anche questa bella narrazione di una crescita espansiva e sostenibile, green, è una balla, non può funzionare per dei motivi molto semplici. Noi viviamo proprio all’interno di una narrazione di irresponsabilità che deve restare miope altrimenti non può riprodursi e da questo tipo di narrazione politica, che è anche narrazione del mondo adulto, non si può produrre una pedagogia attenta ai futuri. Sono i futuri stessi paradossalmente a caricarsi di una responsabilità di cui gli adulti non riescono più a farsi carico e sono loro a insegnarci qualcosa. A insegnarci per esempio che non c’è un pianeta B. La loro protesta è molto interessante perché è un’azione assolutamente responsabile, a prescindere dalle facili critiche che si possono muovere a questi giovani. Però c’è un punto fermo che io tendo a sottolineare e cioè che sono giovani che protestano contro gli adulti non per avere di più, ma perché loro stessi sono pronti ad autolimitarsi affinché altri possano avere almeno altrettanto. Dunque questa protesta è improntata a un senso di responsabilità molto forte da cui noi adulti dobbiamo imparare. La critica delle forme di queste proteste non deve essere tale da nascondere il nucleo fondamentale di queste rivoluzioni che è genuino e dev’essere un monito per tutti noi adulti.
L’8 febbraio 2022 è stato modificato l’articolo 9 della nostra Costituzione in materia di tutela ambientale e animale. Cosa ne pensa?
Sì, tra l’altro è stato aggiunto che lo Stato tutela gli ecosistemi e l’ambiente anche negli interessi delle generazioni future. La Costituzione è quel documento che descrive e dice chi è il noi politico che essa stessa riflette. Dunque la Costituzione siamo noi, la nostra identità politica e oggi quel noi non può essere più limitato a quell’hic et nunc, al presente, ma a un noi che deve guardare al futuro, a una coabitazione e una responsabilità di matrice intergenerazionale. Questo è il grande compito dinanzi al quale noi ci troviamo e che richiede una forma di vero e proprio rivoluzionamento etico, politico e giuridico, come la modifica della Costituzione testimonia in modo assai plastico.
Professore lei è pugliese di nascita. Quando le è capitato di tornare nella sua San Giovanni Rotondo ha notato dei cambiamenti intergenerazionali nella nostra terra?
Sì, sono pugliese e ci torno sempre volentieri. Il mio ritorno è sempre carico di nostalgia e la nostalgia è pericolosa, perché tutti i discorsi nostalgici contaminano la realtà dei fatti e la contaminano sempre in modo negativo. In qualche modo la nostalgia è sempre il rimando a un’età passata intesa come un momento migliore, più puro. Tendenzialmente la nostalgia ha un indice totalitario, tutti i discorsi totalitari inneggiano a questo passato più puro, più vero. Quindi non voglio fare un discorso nostalgico. Le voglio dire che nel tornare in Puglia continuamente ciò che colgo di positivo è una forma di narrazione nuova che quasi riflette la geografia di questa regione. La narrazione del passaggio, dell’inclusione, di questa regione che non si chiude, che è una lingua di terra porosa e nella sua geografia è un’infra, Hannah Arendt diceva “in between“. Noi ci troviamo in una realtà in cui tendenzialmente i discorsi della chiusura, dell’esclusione, stanno ritornando in auge, e invece proprio l’inclusione, la commistione e il passaggio è qualcosa che a me piace ricordare nella nostra regione. Sono contento che questo tipo di narrazione sia stata un investimento che intravedo perlomeno culturalmente nella Puglia degli ultimi anni, proprio come controcanto e antidoto alla chiusura, alla strisciante xenofobia diventata di nuovo uno dei grandi temi al centro della politica. Vorrei opporre appunto l’immagine del ponte, del passaggio, della porosità, a quello che implica la chiusura. Un autore a me caro, con il quale per un tempo ho collaborato, Bernhard Waldenfels, diceva proprio questo, che bisogna stare attenti alle politiche dei muri, delle chiusure, perché chi costruisce muri non li costruisce mai contro gli altri, ma ogni volta li erige contro se stesso. Ecco, io amo quest’idea della Puglia come linea di passaggio, come ponte invece che muro.