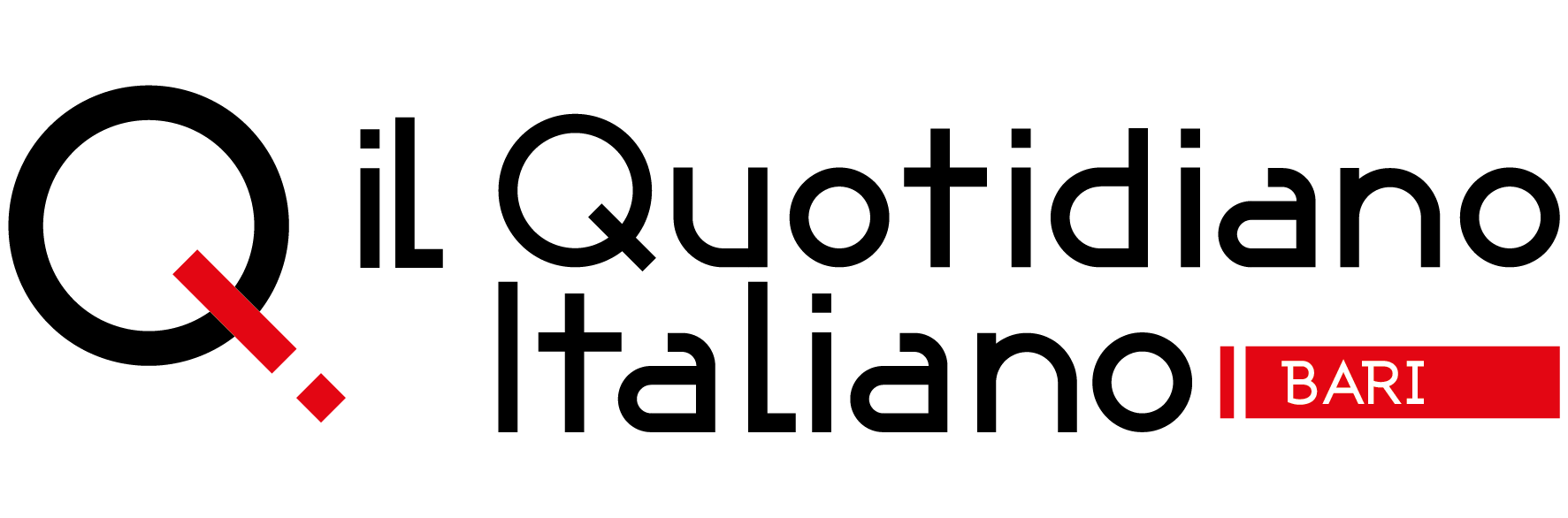Sarà che amo tutte le sofferenti, appassionate e sciaguratamente anche sfortunate donne di Puccini. Sarà che resto ammutolito davanti alla donna teatrale che ama, prega e muore, un suadente connubio che parte dalla Tatiana dell’Evgenij Onegin e finisce alla Leonora de Il Trovatore, passando per Aida (il caro Giacomo riuscì a radunare tutte e tre queste grandi donne in Suor Angelica!). Eppure, nonostante le sue entrate trionfalistiche, il suo corpo giovane e sinuoso, il mistero glaciale che la accompagna, Turandot finisce per cedere il passo a Liù a fine opera.
Forse perché Puccini le affida tre pregevolissime arie, due nel finale dell’ultimo atto, che, anche se incompleto, funziona perfettamente con quel plumbeo ma sereno Mi bemolle minore conclusivo. Oppure perché il compositore non resiste al suo proprio retaggio compositivo e la fa rinascere martire e donna, mentre Turandot resta cristallizzata dal suo stesso gelo, sola nella sua fredda stanza e piena di rimorsi.
L’opera non poteva essere terminata. In preda ai terribili dolori dovuti al cancro alla gola, Puccini dipinse l’invisibile Liù cercando allo stesso tempo di tratteggiare i lineamenti di una storia che difficilmente sarebbe potuta finire con letizia. La sua Liù era diventata troppo vivida, perfetta alle orecchie degli ascoltatori: già la seconda aria avrebbe potuto chiudere l’affresco sia di un personaggio dalle linee man mano più rimarcate che di una poetica compiuta nella contemporaneità e innovazione.
Ma sarebbe mancata la marcia funebre, il suo privato, introspettivo requiem come fu per Mozart e Verdi (e perdonatemi se ne tralascio altri di pari importanza). Il Giacomo ammutolito dalla propria malattia lascia parlare solo la sua penna: è lei che ne decreta il finale mentre la voce è perduta forse per sempre. Niente più favole, niente più fuoco della vita né ghiaccio della morte, solo l’oltre: unicamente un incedere lento e ombrosamente estatico che erige l’ultimo obelisco di un compositore morente. Ci ritroviamo fermi e silenziosi di fronte all’ultima donna dalla dignità superiore a quella di una Regina, all’ultimo alito di arte tra le chiaroscurali frange dei molteplici bemolli, e all’ultima eredità sacra e monolitica del Puccini grande fedele a Dio.
Bari ha la fortuna di ritrovare di nuovo, a casa propria, l’allestimento del maestro napoletano Roberto De Simone, che ha girato molti teatri prima di fare ritorno nel posto in cui ha visto la luce nel 2008, il Teatro Petruzzelli. Ma oltre questo ridotto confine mi taccio in quanto sono già un dipendente della Fondazione ed è più giusto che sia il pubblico a giudicare, anche se vantarsi degli ottimi frutti della propria terra è un onore quanto un dovere, e andrebbe fatto più spesso.