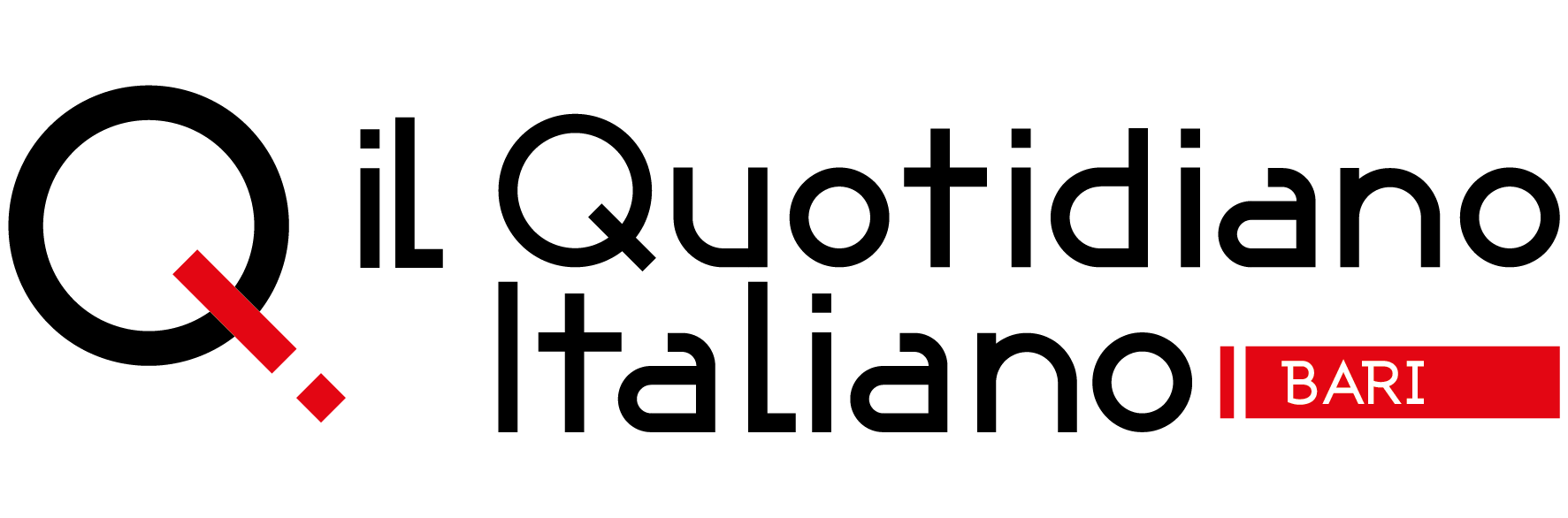“Le lacrime che versiam son false”? O l’autore ne ha ricavato uno squarcio di vita? Due affermazioni decisamente contrastanti, ma che nella messa in scena di Pagliacci, a firma Marco Bellocchio convivono serenamente. Per chi non lo conoscesse, Bari ha recentemente ospitato il regista de “I pugni in tasca” un capolavoro senza tempo del cinema annoverato tra le 100 pellicole italiane da salvare in assoluto. “Pagliacci” della stagione 2014 al Teatro Petruzzelli di Bari, viene inscenato inaspettatamente da solo.
Dopo circa un’ora e un quarto è già tutto finto: l’impressione è quella di alzarsi da tavola dopo aver mangiato il primo e con ancora un grande appetito. Bellocchio ambienta la vicenda in una prigione dall’ubicazione imprecisata. Ottime le scene di Giovanni Carluccio, costruite magistralmente dal laboratorio Petruzzelli, che si consolida ormai come una vera eccellenza. Breve considerazione: è la seconda volta che un regista cinematografico porta una ventata di grigiore indigesto al Petruzzelli: la prima volta avvene per la notevole – e anche costosa (più di 800mila euro) – Elektra di Amelio.
Sarà una deformazione professionale dovuta all’occhio cinematografico? Perché certe vicende di morte, peraltro ambientate nel meridione, vengono tramutate nel rosso del sangue (immancabile ormai) e nel grigio delle scene? L’idea di ambientare l’opera di Leoncavallo in un carcere mette a nudo tutta la componente folle e violenta di “Pagliacci”. L’idea che l’umanità intera sia altrettanto interamente prigioniera è un concetto che fende la platea dal primo istante: i quattro incarcerati/pagliacci sono in cella, osservati giorno e notte da invadenti telecamere a circuito chiuso (la cui immagine è accessibile al pubblico poichè proiettata sul fondo della scena), che spia i loro unici momenti sinceri.
Questo minuscolo e privato brandello di apparente verismo umano sbatte contro un seducente impianto labirintico di finzione, dove la vita e la messa in scena si scambiano così repentinamente gli abiti da far smarrire l’orientamento dello spettatore. Aiutato dalla partitura Leoncavalliana che si rivela un vero e proprio capolavoro sia musicale che teatrale, Bellocchio rigenera nella musica il suo intrinseco sistema di scatole cinesi della finzione contro la vita reale. Ma cosa avviene, parafrasando Schrödinger e il suo gatto, all’interno della scatola più piccola, quella del vero più autentico e cioè sotto il volto infarinato di Canio?
Bellocchio nega al suo spettatore una qualunque versione della verità tradizionale. Ha dotato gli interpreti di maschere multisfaccettate, al confine con la follia, dove l’ultimo enorme teatro è nell’espressione di Canio/Pagliaccio (un ottimo Stuart Neill), che durante la commedia ostenta un agghiacciante sorriso, sebbene si appresti a commettere un uxoricidio. Egli è imprigionato più che dal luogo, dal suo amore per Nedda e dalla malvagità del falso amico, Tonio. Anche Nedda/Colombina (brava anche Maria Katzarava) da buona donna contemporanea, esibisce la sua rivendicazione di indipendenza verso il suo futuro assassino, a costo della morte. La sua aria si tramuta in struggente desiderio di libertà, da tutte le prigioni nelle quali è costretta.
Il punto culminante è un vero e proprio litigio furibondo, dove la violenza (seppur contenuta) di uno contagia tutti gli interpreti e dove l’autentico verismo della musica si sublima nella proiezione di una metafisica umana attuale e autenticamente ipocrita. Un cast generalmente buono, anche se con incertezze dal punto di vista linguistico da parte degli stranieri: se da una parte si apprezzano le doti vocali e sceniche, certe deformazioni vocali purtroppo distolgono dalla scena. In particolare Francesco Marsiglia, elegante ed efficace nella serenata così come in tutto il ruolo. Qualche incertezza espressiva in Alberto Gazale, che ha approcciato il prologo con impensata violenza: sarà stata l’emozione della prima?
La direzione di Carignani è oramai a noi stranota: basandoci esclusivamente sull’ascolto, diciamo solo che l’orchestra ne è uscita a testa alta pur sacrificando parecchie sfumature espressive, a tratti l’insieme e infine alcune incertezze da parte delle prime parti. Buono il coro (magistralmente istruito da Franco Sebastiani) che si è sforzato finchè ha potuto di tenere insieme i cocci di un’amalgama ondeggiante.
Per una Fondazione come quella di Bari, che ha alle spalle un recente “Ring” di Wagner, sicuramente la messa in scena di “Pagliacci”, così da sola è riduttivo se non disonorante. Sebbene la gestione commissariale può essere considerata ormai un ricordo, il sovrintendente Biscardi si ritrova con un lascito artisticamente ed economicamente difficile. A lui, che ne è sicuramente capace, auguriamo un luminoso futuro, dettato da integrità e meritocrazia e non dall’arroganza, contraddistinto dalla considerazione del territorio e delle sue caratteristiche. Chissà, magari dopo aver fatto luce e preso atto del rimbombante passato recente della Fondazione Petruzzelli.
La Civetta