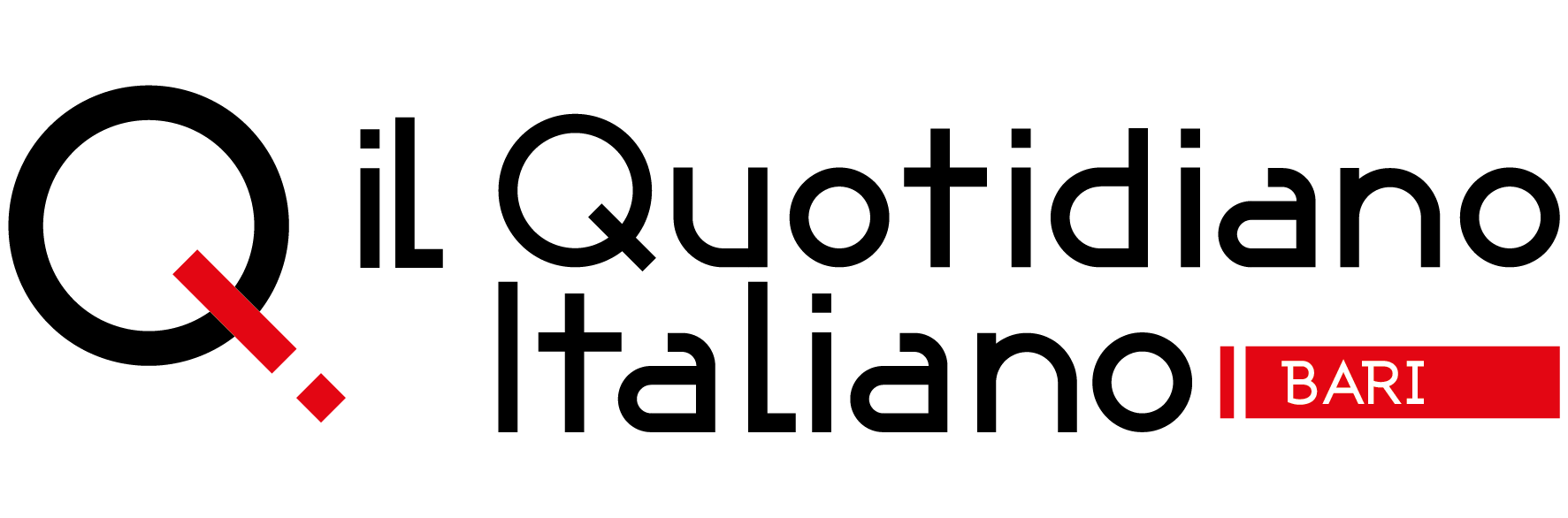Nonostante sia arrivata in condizioni drammatiche al trapianto, l’intervento – durato più di 8 ore – è riuscito. In questi casi si dice così. I medici sono cautamente ottimisti. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire come il nuovo fegato risponderà, se ci saranno complicanze di qualche tipo. Come ho fatto finora continuerò ad affidarmi al Signore. Se penso che al Policlinico di Bari avevano deciso di lasciarmi morire, mi viene una rabbia difficile da spiegare con le parole.
Qualcuno – non è questa la sede opportuna per fare i nomi – ha giocato a fare Dio, stabilendo che il rischio fosse troppo altro e quindi non era il caso provare a salvarmi la vita. Si sono rifiutati di farmi una gastroscopia. Neppure m’hanno chiesto cosa pensassi, se avessi voluto assumermi la responsabilità di un’eventuale emorragia. Non puoi dire a un paziente, a maggior ragione se ha 57 anni: “Mi dispiace, ma ormai c’è poco da fare”, se prima non hai fatto tutto il possibile per salvarlo.
Mi dispiace è la resa dopo la lotta, dopo averle provate tutte per restituire una speranza. Il medico che mi aveva in cura al Policlinico, pur sapendo che i colleghi erano contrari a farmi fare gli ultimi esami utili per l’inserimento nella lista d’urgenza per il trapianto di fegato, ha aspettato alcuni giorni prima di dire a mia figlia la frase che nessuno vorrebbe mai sentire: “Ci stiamo provando da alcuni giorni, ma qui gli esami non glieli fanno, se fosse mia madre oggi la porterei ad Ancona”. Forse non starei lottando tra la vita e la morte se quel medico avesse detto subito che a Bari avevano scelto di non farmi il trapianto.
Si è preferito non contrastare le decisioni dei baroni e degli pasudo luminari, per evitare che fossero intaccate le statistiche di successo, per la paura di una battaglia medico-legale. Non vi siete voluti mettere in discussione, forse perché siete troppo abituati a giocare con le vite umane. Nemmeno la raccomandazione del direttore generale è servita ad autorizzare il trasporto in ambulanza, aereo o elicottero, agli Ospedali Riuniti di Ancona, dove mi era stato riservato un posto in Gastroenterologia. Trasporto che ho dovuto fare con un’ambulanza privata, accompagnata da due medici e un infermiere che mi hanno tenuta stabile fino ad Ancona.
Persone eccezionali alle quali ho affidato la mia vita perché nei loro occhi ho avvertito il senso della vocazione che li ha spinti a indossare un camice bianco. Non conosco che piani Dio abbia per me, certamente non erano quelli che avevano stabilito al Policlinico di Bari, dove a fare questo è “La medicina ragionieristica e difensiva”. Avete letto bene. Cito alla lettera ciò che ha risposto per sms chi ha il dovere di evitare storie come la mia, interpellato da mio genero. Non so se sarò mai più la stessa persona, se avrò danni permanenti, se riconoscerò chi adesso sta lottando per me. Non riesco a smettere di pensare a quanti sono morti perché hanno creduto alle parole dette in malafede.
Mi dicevate continuamente che il mio caso era drammatico, ma non mi avete fatto un solo esame per tre sabati e tre domeniche. Dottore, direttore generale, assessori, rappresentanti delle istituzioni tutte, sarebbe stato così anche se al mio posto ci fosse stato vostro figlio, vostra madre, una qualsiasi persona che amate e per la quale avreste dato la vostra vita? Indipendentemente da come andrà a finire, con la mia famiglia abbiamo scelto di andare fino in fondo.
Prima di lasciarvi vorrei ringraziare dal più profondo del cuore l’équipe del professor Marco Vivarelli, il dottor Tarsetti, il dottor Nicolini, il professor Mosca, il personale della Rianimazione e del reaparto di Gastroenterologia degli Ospedali riuniti di Ancona. Mi hanno sempre messo davanti alla realtà, ma al tempo stesso non mi hanno mai fatto mancare un sorriso e quel senso di protezione che mi ha aiutato a guardare avanti con un pizzico di speranza in più. Si può morire – prima o poi succede – ma andarsene dopo aver lottato non ti lascia rimpianti.