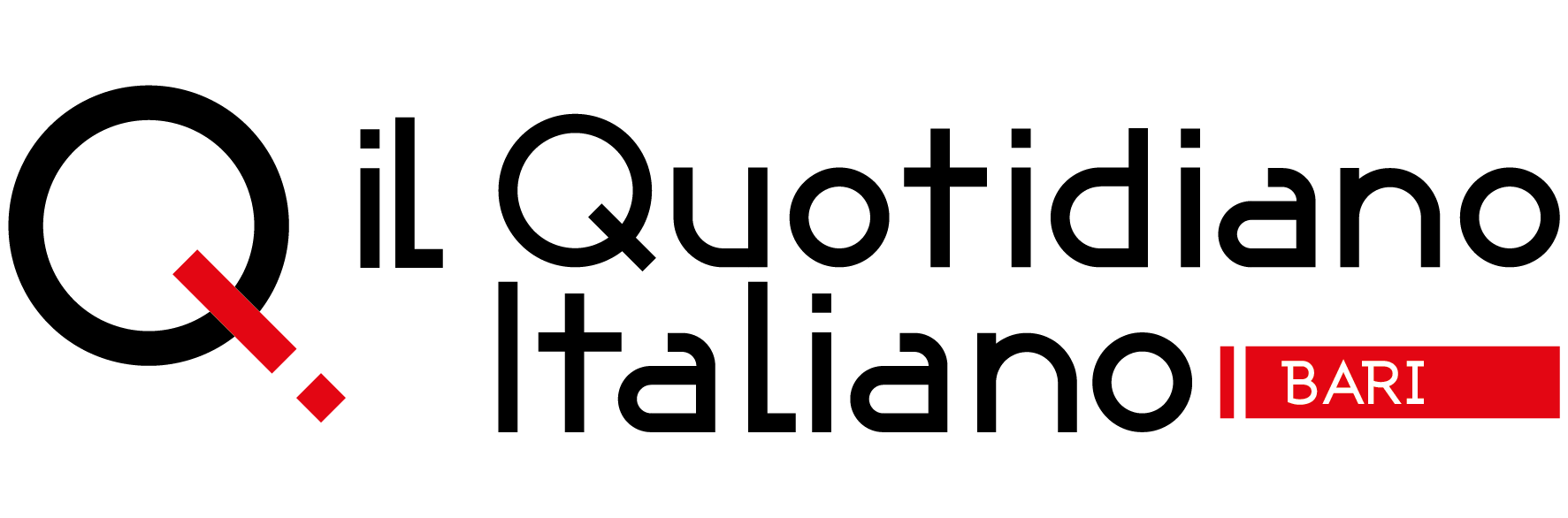Il Primo maggio in cui sui palchi si cantavano canzoni in grado di graffiare e pungere cuori e coscienze. Il giorno delle piazze piene e di alcune parole da scandire ad alta voce, così, tanto per non mollare all’idea che un cappio al collo potesse essere la scelta migliore: diritti, lavoro, priorità, salario, protesta, indignazione. In assoluto ordine sparso.
L’indignazione sta pericolosamente diventando rassegnazione: “tanto sarà sempre così”. Non sento più urlare slogan dai megafoni sistemati sul tetto di un’auto pronta a ricordare ai concittadini orari di comizi e manifestazioni popolari, con il sindacalista locale o persino il segretario nazionale. Non ci sono più sindacalisti a disposizione perché sono tutti seduti attorno a un tavolo tecnico o di concertazione, a una conferenza di servizi a fare i politici. Persino i comunicati stampa si sono appiattiti, sembrano tutti scritti dalla stessa mano. Collegata al cervello, sì, ma distante anni luce dalla passione di Di Vittorio.
Alla radio ho ascoltato la protesta dei leccesi, sconvolti dall’idea di dover rinunciare alla gita fuori porta perché il Primo maggio c’è da lavorare. Menomale che ancora qualcuno il lavoro ce l’ha! Nessuna demagogia, men che meno retorica, ma è come quando il bambino lascia l’ultimo boccone nel piatto. Ce l’avete presente la tiritera? “Mangia tutto, pensa a chi non hanno nemmeno un tozzo di pane”. Fanno bene a indignarsi i lavoratori che non hanno respiro, ma bisogna tornare a pesare il valore delle parole, a pensare che qualcuno farebbe i salti mortali pur di lavorare e portare di tanto in tanto i propri figli fuori porta, quella di casa, che ormai quasi non si varca più per la vergogna di essere stato accantonato a 50 anni o, a 30 anni, per non aver mai lavorato. Un’occupazione vera, una di quelle che ti permette di programmare un matrimonio, l’acquisto di una casa, la normalità.
Per chi continua a cercare un lavoro o ha addirittura ha smesso di andare a trovarlo, il Primo maggio è solo un altro giorno, come quello prima e quello che verrà. E chissà come sarà. E’ il giorno degli esodati, dei cassintegrati, di chi si ammazza o pensa di farlo, dei precari, di chi vive con la mobilità o si aggrappa a un contratto di solidarietà, dei lavoratori in nero, dei pensionati ancora in servizio attivo, dei giovani costretti a scappare, dei giovani obbligati a non smettere mai di studiare, di chi il lavoro ce l’aveva e l’ha perso per un capriccio del padrone.
Il Primo maggio non può perdere il suo altissimo valore simbolico, non può essere paragonato alla festa di San Valentino o alla giornata mondiale del balcone fiorito. Qualcuno s’è fatto ammazzare perché un giorno si potesse scendere in piazza, si potessero rivendicare diritti negati, si potesse usare un megafono.
30 aprile 2012
Antonio Loconte